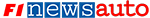F1 NEWS | Nuovi crash test per le monoposto di F1 dal 2026
Con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico del 2026, le verifiche strutturali saranno ancora più articolate e impegnative. Ma come si effettua, in concreto, un crash test su una monoposto? E quali elementi vengono messi alla prova?

Con il cambio regolamentare alle porte della stagione agonistica 2026, le squadre di Formula 1 stanno affrontando una delle sfide più insidiose dell’intera transizione tecnica: l’omologazione del telaio mediante crash test. I nuovi standard imposti dalla FIA per il 2026 alzano l’asticella della sicurezza, imponendo verifiche più stringenti, test d’impatto più aggressivi e simulazioni strutturali inedite. Il risultato? Un equilibrio sempre più complesso tra resistenza strutturale e contenimento del peso, due fattori che influenzeranno direttamente le prestazioni in pista.
Nuovi crash test F1 2026: una scocca da reinventare
Le attuali monoscocche, se osservate in configurazione “nuda”, potrebbero sembrare simili a quelle in uso nel 2025. Ma la verità è che le richieste della FIA sono cambiate radicalmente. Non basta più superare i consueti crash test: ora occorre dimostrare che la struttura sia in grado di assorbire impatti in scenari più numerosi e a intensità più elevate.
Tra i vari punti critici spicca il musetto anteriore, per il quale verranno introdotti due test distinti: oltre alla tradizionale prova d’impatto, i team dovranno affrontare una sequenza che prevede prima la deformazione forzata in un’area specifica (push-off) e poi un nuovo crash test per verificarne la tenuta residua.
Le procedure dei nuovi crash test per le monoposto di F1
Ogni monoposto di Formula 1, prima di essere omologata e ammessa in pista, deve superare una serie di crash test imposti dalla FIA, studiati per garantire che la vettura protegga efficacemente il pilota in caso di incidente. Il processo è rigoroso, metodico e coinvolge sia simulazioni virtuali sia prove fisiche reali, con parametri di valutazione molto stringenti.
La prima fase è digitale: i team devono fornire alla Federazione una documentazione completa di simulazioni strutturali realizzate con software FEM (Finite Element Method), che ricostruiscono virtualmente gli scenari di carico previsti dal regolamento tecnico. In questa fase si verifica la risposta teorica della scocca a impatti frontali, laterali, posteriori e verticali, così come la capacità di dissipare energia senza compromettere l’integrità dell’abitacolo. Solo se i dati sono coerenti con i requisiti normativi, si può passare alla fase successiva.
I crash test fisici rappresentano il cuore del processo di omologazione. I componenti principali della vettura, tra cui cellula di sopravvivenza, musetto, paratie laterali, zona posteriore e struttura roll-bar, vengono costruiti in scala 1:1 e sottoposti a urti controllati. Gli impatti avvengono su banchi dinamici e seguono parametri estremamente precisi: velocità di collisione (es. 14 m/s per il muso), massa impattante, angolazione del colpo e zona bersaglio. Vengono utilizzati sensori ad alta precisione e manichini strumentati per misurare forze di decelerazione e deformazioni.
L’obiettivo non è soltanto che la vettura resista, ma che si deformi in modo controllato, assorbendo l’energia dell’urto in aree specifiche, mantenendo intatta la cellula di sopravvivenza dove si trova il pilota. La struttura deve anche evitare distacchi pericolosi di parti e deve restare integra in caso di ribaltamento. Un test fondamentale è quello del roll hoop, il roll-bar dietro la testa del pilota, che deve resistere a forti carichi verticali e laterali senza collassare.
Nel caso anche solo uno dei test venga fallito, il componente va ricostruito, e l’intero processo dev’essere ripetuto da capo, con conseguenze significative su tempi e costi. Solo dopo aver superato tutti i test obbligatori, la vettura riceve il nulla osta per scendere in pista, anche nei test prestagionali.
Come superare la fase di omologazione crash test in F1
Il processo di approvazione da parte della FIA si basa su una combinazione di calcoli ingegneristici, simulazioni virtuali e test fisici. Ma l’inasprimento delle procedure ha generato un effetto domino. In caso di esito negativo in uno dei test, la squadra sarà costretta a realizzare un nuovo telaio, con inevitabili ripercussioni su tempi e costi. Un rischio particolarmente serio in vista della finestra di test prestagionali fissata per la fine di gennaio.
E non è tutto. La nuova generazione di telai, più resistenti e complessi, comporta un potenziale aumento del peso complessivo delle monoposto. Situazione critica se pensiamo che in F1 ogni grammo conta, figuriamoci dei chili extra. “Il peso sarà una sfida notevole”, ha confermato De Zordo. “Raggiungere i limiti minimi previsti sarà molto complicato. Non è detto che ci riesca qualcuno già nel 2026”.
Aerodinamica a due facce
La questione telaio si somma a un’altra novità tecnica rilevante: l’introduzione di una doppia configurazione aerodinamica, che comporterà due assetti standard da utilizzare durante un singolo giro. A differenza del DRS, finora limitato a brevi tratti, le nuove ali mobili influenzeranno l’intero comportamento della vettura su più sezioni del tracciato.
Secondo De Zordo, questo cambiamento rende persino la raccolta dati in galleria del vento più complicata rispetto al passato. I team dovranno trovare un nuovo compromesso tra efficienza e bilanciamento, considerando che la monoposto dovrà alternare due vesti aerodinamiche con continuità. Un ulteriore livello di complessità che si somma a quello strutturale.
Considerazioni delle squadre
Andrea De Zordo, direttore tecnico della Haas, ha commentato la questione durante una recente intervista televisiva al programma The Tech Formula, parlando di una complessità che ha messo sotto pressione ogni team del paddock.